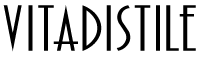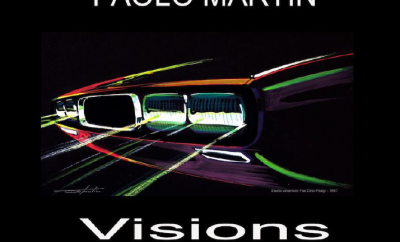Federico Vandone dell'Acqua
Federico Vandone dell'Acqua
Auto
Paolo Martin: felicità, forma, emozioni

“Io lavoro fuori dal tempo” . L’Arte riesce a sottrarsi alle forza del tempo, lo piega. Paolo Martin non pensa al tempo, lavora in una condizione in cui il tempo non ha segnato il suo modo di pensare, ha accumulato esperienza anche se non si stupirebbe se Michelotti uscisse da dietro l’angolo con in mano un disegno abbozzato e gli chiedesse di fare qualcosa in mezzo a quei due fanali.

Lo stato di grazia della sua creatività non è stata intaccata dalle mode, dalle correnti di pensiero, dal nuovo di modo di fare design. La Dino Berlinetta Competizione forse non verrebbe disegnata allo stesso modo ma di certo avrebbe una forma che lascerebbe incantati come quella dell’originale, la macchina “felice” che non poteva essere altro che il risultato di uno sforzo creativo altrettanto felice, libero da condizionamenti in cui la fantasia ha tratteggiato una forma che nel 1967 quando la Ferrari produceva la 365 GTB/4 Daytona questa appariva come la cugina piovuta dall’asteroide B-612. La forma della Dino Competizione è stata assimilata ad un violino, in realtà non è il violino ma è la melodia che prende forma dallo strumento. La forma della 206 muta negli occhi di chi la guarda, evolve con l’evolversi dell’osservatore in un divenire sempre pronto a restituire l’emozione che le ha donato l’ anima. Non teme confronti, non è figlia del suo tempo, non invecchierà mai, non passerà mai.

Martin è un designer intimamente legato alla materia, alla tattilità delle forme. Sul tavolo ha un boomerang, appena fatto per raccogliere la sfida lanciatagli da un giornalista. Senza studi, senza documentazione, l’idea ha preso forma. L’idea è emozione e prende forma solo per farsi visibile. La forma segue la funzione e non viceversa, perché quello che il designer fa innanzitutto deve essere utilizzato, avere uno scopo preciso. Sia che si parli di barche, automobili, motorini o scarpe, il processo di immedesimazione traduce l’idea nella sua forma definitiva che porta con sé la risposta ad un bisogno.

E’un flusso ininterrotto di intuizioni ed emozioni quello che porta a creare.
Paolo ripercorre gli anni delle prime esperienze, dagli anni di Michelotti alla parentesi alla Bertone, la consacrazione alla Pininfarina, alla Ghia dove si cimenta con le moto fino alla libera professione. Su tutti il Maestro di una vita rimane Michelotti.
Chiacchieriamo a ruota libera, riprendendo il filo del discorso lasciato nel 2014 e spaziamo dal concept della nuova Rolls Royce Camargue realizzata da Paolo per il cinquantenario dell’automobile più controversa uscita da Crewe, alle moto, al nuovo libro “Martin’s bikes” che uscirà dopo metà 2017. Quando si parla di moto disegnate da Paolo Martin si parla di Gilera, Guzzi, Benelli, i marchi che appartennero alla galassia De Tomaso.

Paolo, hai conosciuto De Tomaso da vicino. Che ricordi hai?
De Tomaso era, come ho scritto nel mio libro, un “appaltatore di peones”. Aveva il business nel sangue. Non pretendeva di capire come si facevano le cose, ci lasciava libertà di decisione sulle soluzioni. A lui interessava risolvere il problema e andare in produzione, a vendere ci pensava lui. Mi ricordo quando facendo lo slalom tra le vetture in costruzione alla Ghia entrò in tombino con una Vespa e cadde (rovinosamente). Non credo che sali più su nessuna moto. Nel 1972 mi chiese di fare il restyling della Pantera disegnata due anni prima da Tom Tjaarda, proposi la mia soluzione che come tutte le mie opere era slegata dal tempo, era la rappresentazione tridimensionale dell’emozione. Non gli piacque, purtroppo. Oggi sarebbe con la Modulo e la Dino Competizione una delle più riuscite espressioni della creatività.

Michelotti è stato il Maestro a cui devi di più, perché?
Da Giovanni Michelotti ho imparato tutto. Mi ha dato le cartucce giuste che poi mi hanno permesso di essere assunto da Nuccio Bertone prima e di crescere dopo. Michelotti mi ha insegnato l’arte, gli strumenti, è stato un esempio. Dopo quattro anni da lui sapevo disegnare una vettura in scala 1:1, rappresentare le sezioni, modellare i figurini, creare. Da lui ero un esecutore curiosissimo, realizzavo modelli, manichini, mi confrontavo direttamente con il compito che mi veniva assegnato. I giapponesi mi chiamavano “MMM: Martin Master Monster”, non credevano che una persona da sola sapesse fare un’ automobile completa.

Il periodo Bertone. Una breve parentesi nella tua storia professionale. Perché?
Si, la mia permanenza da Bertone durò effettivamente poco, circa 10 mesi e non fu un esperienza molto positiva. Dopo andai alla Pininfarina e iniziò un periodo ricco di soddisfazioni. Quando arrivai da Bertone si stava disegnando la Miura: Giugiaro e lo stesso Nuccio Bertone avevano quasi finito la macchina. Gandini stava facendo il make-up del frontale e qualche dettaglio. In quel periodo disegnai il logo della “b” stilizzata, a Bertone piacque subito e venne subito messo su tutte le vetture prodotte. Da Bertone c’era una gran confusione, non c’era un ufficio tecnico con cui confrontarsi. La differenza la facevano le maestranze, il capofficina che in quattro mosse magari riuscivano a far chiudere una porta in un modo impossibile; senza disegni ovviamente, quelli non si riuscivano a fare. Il capitale umano era la grande ricchezza di Bertone. Ricordo in Bertone, il capofficina Cingolani, risuciva a tradurre in realtà i disegni di stile senza che esistessero quelli tecnici. Io facevo delle vetture anche per telefono, ci capivamo, c’erano step precisi e definiti. Tutto era più rapido.
La Modulo e la Dino 206 Competizione, due concept che hanno lasciato il segno nel design automobilistico.
La gente non era preparata a queste forme. Ricordo di confronti accesi tra Pininfarina e Carli su quello che avrebbe potuto dire la stampa sulla Modulo, alla fine però si fece il prototipo così provocante ancora oggi. I diffusori sferici della ventilazione sono ricavati da palle da bowling. Non esistevano macchine a controllo numerico e non erano forme realizzabili con il tornio: dovevamo adattare quello che si trovava. La Berlinetta era la mia idea di supercar, la feci nella mia casa di Via Lancia, a Torino, disegnando sul balcone di casa e realizzando il modellino. Non ero influenzato da nessuno, l’ho realizzata in maniera emotiva, una forma sensuale che Rosinski ha definito uno degli oggetti più belli realizzati dall’uomo perché esprime felicità. Io sono sempre stato felice quando lavoravo, la mia felicità prendeva forma in quello che facevo.
Quelli erano gli anni formidabili in cui nel 1967 anche un giovane battilastra, Giancarlo Guerra, alla Carrozzeria Scaglietti poteva concepire una delle più iconiche Ferarri di sempre, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona definendone lo stile al punto che l’Ing. Fioravanti, entrato alla Pininfarina nel 1968, dovette apportare solo poche modifiche di dettaglio.

La forma e la funzione. Il rapporto con il tempo
Creo automobili slegate dal tempo e legate alle emozioni , trasformazione dell’emozione di un pensiero. Già domani verrebbe diverso. Non sono legato a nessuno schema, quello che faccio non è quindi vincolato a nulla se non alle esigenze dettate dall’uso. Il mio lavoro può essere letto come un flusso di emozioni non regimentato se non dalla mia sensibilità. Il restyiling della Pantera del 1972 ne è la prova, una vettura che sarebbe meravigliosa oggi ma che non venne capita e finì i suoi giorni sopra le latrine della Ghia. Fu l’unico spazio che (De Tomaso, nda) riuscì a trovare.
Con l’immaginazione riesco ad immedesimarmi in chi ha creato un oggetto perché venisse utilizzato e ne scorgo l’anima, lo spirito del creatore che ha saputo rispondere ad un bisogno complesso. Io sono come l’uomo delle caverne che creava la freccia per sopravvivere con la caccia, mi immedesimo nel processo creativo per creare oggetti che rispondano a delle esigenze, finalizzate all’uso.
Oggi l’automobile non ha più un’anima, non le si chiede più di averla. L’utenza è cambiata, la cultura è cambiata. Si acquistano le vetture per il prestigio che danno, non certo per l’uso o perché ci si emoziona. Sono cultori dello status symbol quelli che acquistano le super-car oggi, nessuno è più interessato a percepirne l’anima. Lo stesso Glickenhaus quando ha restaurato la Modulo non ha cercato di finire la vettura nel rispetto di come era stata pensata, preferendo la telecamera agli arditi specchietti e il colore bianco rispetto al celeste originale.

Forma, esperienza e futuro. Rapporto possibile?
Non mi sono mai ispirato alle linee esistenti, ma ho dettato linee per il futuro. Nel momento in cui creo, le sensazioni immagazzinate fanno affiorare le forme e i dettagli vengono come conseguenze dell’esperienza ed è proprio l’esperienza che è forgiata dalle emozioni e a sua volta imprime il mio DNA nelle forme che faccio. I miei sogni si sono sempre realizzati tutti , da soli, senza calcoli e senza sotterfugi. I sogni sono dei pensieri latenti che ci accompagnano e che ci vengono in mente quando meno ce ne rendiamo conto e l’occasione viene da sé. Ragazzi credete nei vostri sogni!
Creare mi da emozione e non baratterei la libertà con cui lo faccio con niente al mondo.